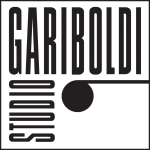Enrico Donati (Milano, 1909 – New York, 2008) è un pittore italo americano surrealista.
Donati trascorre un’infanzia felice, e, dopo essersi diplomato al liceo classico F. Parini, si iscrive all’Università di Pavia.
La sua passione per la musica lo porta, in seguito alla laurea con indirizzo sociologico, a iniziare un corso di composizione al Conservatorio di Milano.
Tra il 1933 e il 1934 Enrico Donati decide di trasferirsi a Parigi in un atelier a Montmartre dove comincia a comporre musica d’avanguardia. Proprio a Parigi, centro artistico molto attivo in quegli anni, comincia a interessarsi alla pittura: dipinge, frequenta le gallerie e visita i musei.
Attratto dalla cultura degli Indiani, nel 1934 decide di compiere un viaggio nel Sud-Ovest degli Stati Uniti d’America e in Canada. Dopo circa tre mesi, rientra a Parigi per poi ripartire per New York, dove rimane fino al 1936.
Nel ‘36 torna a Parigi e si iscrive all’Ecole de la Rue de Berri che gli permette di acquisire una preparazione tecnica nel disegno.
Nel 1939, alla vigilia della seconda guerra mondiale, il futuro in Europa si presenta molto incerto e Donati decide di tornare a New York per portare al sicuro la famiglia.
Leggi tutto
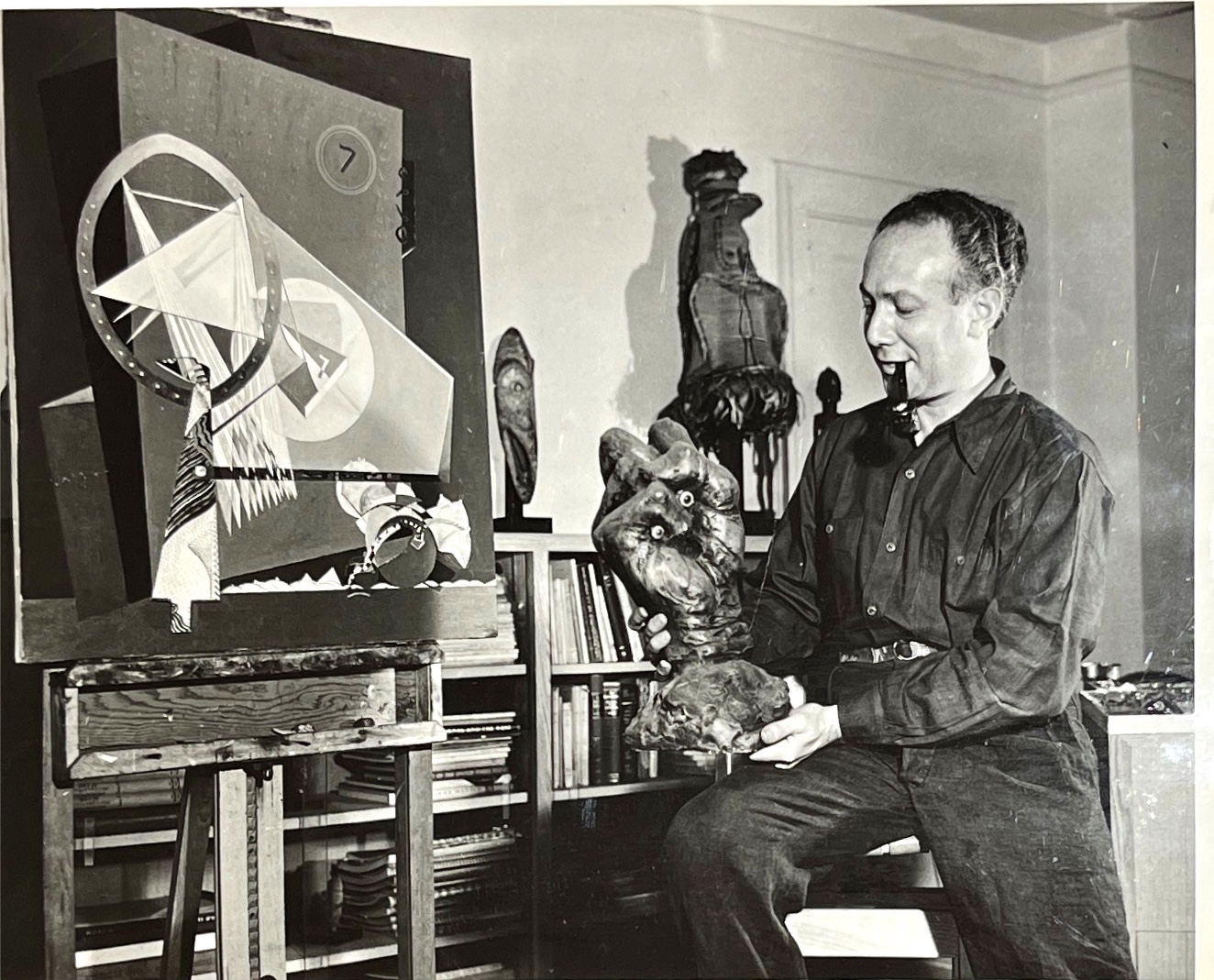
Enrico Donati ©CorradoRota
In Galleria
MOSTRE PERSONALI
2023
Enrico Donati New York Parigi Milano, Studio Gariboldi, Milano, Italia
2022
Enrico Donati, LewAllen Galleries, Santa Fe, New Mexico, Usa
2021
Enrico Donati, Washburn Gallery, New York, Usa
2020
Enrico Donati, LewAllen Galleries, Santa Fe, New Mexico, Usa
2016
Enrico Donati – Prima Materia, Weinstein Gallery, Clementina Street, San Francisco, California, Usa
2004/2005
The Fertile Eyes Gallery, Parigi
2000
Alter & Gil, Beverly Hills, retrospective, Usa
1998
Alter & Gil, Beverly Hills, retrospective, Usa
1997
Boca Raton Museum, retrospective, Usa
Maxwell Davidson Gallery, New York, Usa
1996
Horwitch-Newman Gallery, Scottsdale, Usa
1995
Maxwell Davidson Gallery, New York, Usa
Horwitch-Newman Gallery, Scottsdale, Usa
1994
Louis Newman Gallery, Beverly Hills, Usa
Carone Art Gallery, Ft. Lauderdale, Usa
1992
Carone Art Gallery, Ft. Lauderdale, Usa
1991
Louis Newman Gallery, – Beverly Hills, Usa
1990
Carone Art Gallery, Ft. Lauderdale, Usa
1989
Zabriskie Gallery, Parigi
Louis Newman Gallery, Beverly Hills, Usa
1987
Gimpel & Witzenhoffer Gallery, New York, Usa
Zabriskie Gallery, New York, Usa
1986
Louis Newman Gallery, Beverly Hills, Usa
Gimpel & Witzenhoffer Gallery, New York, Usa
1985
Georges Fall Gallery, Parigi
1984
Carone Art Gallery, Ft. Lauderdale, Usa
Gimpel & Witzenhoffer Gallery, New York, Usa
1982
Joan Ankrum Gallery, Los Angeles, Usa
Staempfli Gallery, New York, Usa
1980
Grand Palais, FIAC, Parigi
Staempfli Gallery, New York, Usa
Palm Springs Desert Museum, Usa
1979
Joan Ankrum Gallery, Los Angeles, Usa
Norton Gallery, Palm Beach, Usa
Osuna Gallery, Washington, D.C., Usa
Phillips Collection, Washington, D.C., Usa
Leggi tutto
MOSTRE COLLETTIVE
2022
Space Oddity, Studio Gariboldi, Milano
Winter Festival, Part One:The abstract painters, LewAllen Galleries, Santa Fe, New Mexico, USA
2021/2022
Arcimboldo Face to Face, Centre Pompidou Metz, France
2018
Moon Dancers: Yup’ik Masks and the surrealists, Upper East Side, New York, Usa
2017
Exilic pleasures: surrealism refuged in America, Leila Heller Gallery, New York, Usa
2015
Fields of dream: the surrealist landscape, Upper East Side, New York, Usa
2014
Surrealism and Magic, Johnson Museum of Art, Cornell University, New York, Usa
2002
Galleria d’Arte Contemporanea Cascina Roma, San Donato Milanese, Italy
2001
Galleria Arte & Arte, Bologna, Italy
2000
Galleria Credito Valtellinese, Sondrio, Italy
Musée d’Art Moderne et Contemporain, Strasburgo, France
1999
Pisa, Villa Pacchiani, Santa Croce sull’ Arno, Italy
Solomon Guggenheim Museum, New York, Usa
1998
Bruce Museum, Connecticut, Usa
Galleria Credito Valtellinese, Sondrio, Italy
1997
Galleria d’arte Bergamo, Bergamo, Italy
Palazzo dei Diamanti, Ferrara, Italy
Boca Raton Museum of Art, Florida, Usa
MIART, Milano, Italy
1996
Modena, Pinacoteca e Galleria d’arte contemporanea – Pavullo, Modena, Italy
Basilica Palladiana, Vicenza, Italy
Studio Amedeo Porro arte moderna e contemporanea, Vicenza, Italy
1995
Galleria d’arte Bergamo, Bergamo, Italy
1994
Miami International, Miami, Florida, Usa
Fondazione Mudima, Milano, Italy
Hunter College Art Galleries, New York, Usa
Isidore Ducasse Fine Arts, New York, Usa
1992
Miami International, Miami, Florida,
1991
ART/LA, International Contemporary Art Fair,Los Angeles, Usa
Museo National Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Spain
Miami International, Miami, Florida, Usa
Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, France
1990
ART/LA, International Contemporary Art Fair, Los Angeles, Usa
Fundacion Cultural Mapfre Vida, Madrid, Spain
1989
Schirn Kunsthallel, Francoforte, Germany
Centro Atlantico de Arte Moderno, Las Palmas, Spain
Palazzo Reale, Italy
Zabriskie Gallery, New York, Usa
1987
Villa Malpensata, Lugano, Switzerland
Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia, Italy
Leggi tutto