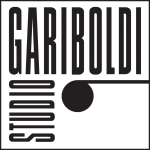aprile – giugno 2013
di Giuliano Zincone, Corriere d’Informazione, 1968
Gli ultimi quadri di Clemente sono ispide geometrie esplose, efflorescenze fantastiche, chiome di sotterranei animali, prati all’inglese fatti di corda. Come tutti gli stregoni, Clemente ha qualcosa di diabolico, si diverte a sgomentare e a sorprendere: crede con ferocia in queste sue spettinate evocazioni dell’aldilà.
Lo spettatore vedrà eruzioni di canapa scaturite dalla tela, superfici percorse da un brivido arduo da definire; e avvicinandosi al quadro rimarrà sconcertato, scoprendo che quegli oggetti minacciosi sono fabbricati con la complicità di pezzi di spago apparentemente innocui.
Eppure è proprio qui l’abilità dell’alchimista: esasperare, disciplinandole, le qualità inaudite (e quindi non innocue) dei materiali più comuni. discorso, naturalmente, vale tanto per i colori quanto per gli oggetti: Clemente, che ammira Kandinsky, lo sa bene. Questo artista aggiornatissimo, che ha vissuto i ruggenti “fifties” di Parigi, questo pittore raffinato e quasi sprezzante di tutto ciò che è frusto e comune, sceglie nella sua stagione più matura un materiale quotidiano e desueto: la corda, appunto, che ormai non serve nemmeno a legare i pacchi.
La scelta è, ovviamente, polemica e se da una parte è in linea con il recupero pop degli oggetti di ogni giorno, dall’altra, ne costituisce un tentativo di superamento (o di confutazione al livello del linguaggio).
Clemente si sente vicino a Bonalumi e ai suoi oggetti di plastica, ama Fontana e, fra i maestri ufficiali, Kandinsky e Mirò, ma è originale proprio per la sua fede disturbatrice della geometria, del prodotto rigoroso e organizzato attraverso (e qui è il paradosso) la geometria, il rigore e l’organizzazione del lavoro. “ Se potessi – dice – farei anche le cornici dei quadri che espongo”. Ma non inganni questo amore per l’artigianato e per il “ben fatto”: i risultati mirano a emozioni opposte, a frecce, triangoli, comete, allucinazioni di corda (anche la marijuana è canapa) scapigliate al punto da minacciare ogni regola aurea della ragione.
Clemente dorme nel letto intagliato di un antico generale dei gesuiti, si scalda con una monumentale stufa liberty, il suo hobby è la visita al rigattiere: è la riprova di un amore per le cose belle e antiche, rivisitate da una fantasia inquieta e quasi frenetica.
Non per nulla Clemente ama Michaux, poeta e pittore dell’indefinibile, non per nulla ha assorbito in Francia , con lo spirito cartesiano, la chiaroveggenza di Artaud.
Il suo segno, che allude a eruzioni incontrollate, non è mai casuale, ma è frutto di una diabolica abilità artigiana, esatta, organizzata, lineare. A questo punto, per lo spettatore incredulo di fronte ai fiori di canapa della mostra al “Naviglio” (monocromie e dicromie che esorcizzano il colore, prima della realtà stessa) sarebbe necessario un lavoro di archeologia: ricostruire la preistoria di Clemente, dalla gestualità del ’57 (“Pollock? Sì, ma più materico”) ai “Tondi” del ’59-’60 (policromie cui molti giovani pittori continuano a riferirsi ancora oggi), dalle “Misure” del ’63 (teorie di immagini nebulose, apparentemente disorganizzate: il momento di tangenza con la libertà extrarazionale di Schifano) alle scansioni esatte di superfici violentemente colorate della produzione che precede immediatamente la mostra di oggi.
Ma questa cronologia, sebbene evidentemente sorretta da una evoluzione continua di linguaggio e di esposizione, coerente e precisa, non definirebbe Clemente, odiatore di ogni catalogo sistematico e devitalizzante. Preferiamo ricordare, piuttosto, l’eclettismo di questo pittore, la sua presenza di artista completo e attento ai trasalimenti del costume contemporaneo più avanzato: un’esuberanza che gli ha consentito di partecipare alle esperienze dell’avanguardia teatrale parigina come coreografo, musicista e scenografo (nella tradizione americana di Oldenburg, Rauschenberg e soprattutto Kaprow, inventore dell’”happening”) e che lo ha fatto partecipe di alcune fra le più interessanti esperienze della televisione a colori francese.
Archeologie di un recente passato
di Francesco Tedeschi
“per l’artista che accetta il nostro tempo, la forma cessa di essere un immobile residuo con un solo significato e si rivela come sintomo di un polivalente Divenire. La forma diviene ‘formazione’ e il pittore è cronista del suo emergere ed esploratore della sua latente latitudine di significati…” (parole di Jack Clemente riportate in P. Rouve, Clemente by Pierre Rouve, in “Art News and Review” Vol. XII No.4, Saturday, March 12th 1960, p.5)
Sono, quelli citati, pensieri di Jack Clemente, originale e pressoché dimenticata figura di artista poliedrico e, in certo senso, apolide. In essi si colgono il senso di inquietudine, la spinta all’invenzione e alla sperimentazione, la corrispondenza fra il fare e il divenire, che costituiscono le ragioni di una inces- sante volontà innovativa. Questa lo ha animato nel tempo, breve e intenso, in cui ha operato: una delle epoche più vive e propositive della storia recente, nella quale le trasformazioni nei modi operativi e nelle ragioni del fare artistico hanno prodotto tante diverse e molteplici soluzioni. Il cospicuo nucleo di lavori ritrovato e presentato in questa mostra costituisce un interessante tassello di quest’epoca, e di una parte della produzione di un artista, che viene così tratto dall’oblio, recuperato con un’operazione che si può definire “archeologica”. Dall’archeologia Clemente ha tratto ragioni di ispirazione, interessi per la creazione di opere che in vario modo dialogano con il passato, il mito, l’origine del tempo. Un senso aurorale e primordiale aleggia nelle sue composizioni “informali”, della seconda metà degli anni Cinquanta, quando, a Parigi, sperimenta tecniche pittoriche che sono in rapporto con il tachisme, con le “materiologie” che derivano dalle proposte avviate a metà degli anni Quaranta, ma in qualche modo si spingono già oltre la pittura in quanto tale. Il segno e la materia, diffusi in uno spazio privo di connotazioni, sono tracce di un tempo senza tempo, evocano luoghi arcani, con qualche retaggio di quel surrealismo che innerva una buona parte della cultura visiva ed espressiva francese e non solo. Di quella stagione di Clemente, che pure ha portato a singolari acquisizioni, poco, anzi pochissimo è oggi noto, e ci si può augurare che un giorno possa essere più ampiamente recuperato, per vie magari fortuite, e ripreso in considerazione. Ciò che è oggi possibile guardare con nuova attenzione è comunque un nucleo consistente della sua produzione più avanzata, iniziata oltre la metà degli anni Sessanta, in un diverso clima. Sono le opere oggi “riscoperte”, in tutti i sensi, realizzate con una tecnica dotata in sé di qualità metaforiche. Le “corde” e i “nodi” con i quali Clemente compone i suoi “quadri” a partire dal 1966 circa sono infatti strumenti e oggetti che si pongono apparentemente ol- tre e fuori dalla pittura, ma conservano la memoria e forse la necessità del quadro. Sono le opere con le quali Clemente si presenta nella sua terza mostra nella Galleria del Naviglio, nel gennaio 1968, dove l’artista chiede che venga pubblicata una pagina di lettere dattilografate in sequenza, al posto di un te- sto critico. Questa e le precedenti, del 1962 e del 1966, sono esposizioni che, con quella nella Galleria del Cavallino di Venezia del luglio 1963, costituiscono un’importante sequenza di presenze, corredata dalla partecipazione ad alcune collettive, nell’ambiente delle due gallerie della famiglia Cardazzo (la prima, nel 1962, deriva dal contatto diretto con Carlo Cardazzo, che morirà l’anno successivo). Nel corso degli anni Sessanta Clemente si inserisce a pieno titolo fra i protagonisti dell’arte italiana, stringendo rapporti con l’ambiente milanese, dove aveva esposto già a metà degli anni Cinquanta. Lo sospingono ora i rapporti instaurati con Dova, Fontana e altri autori del contesto milanese emerso dalla congiuntura dialettica di Spazialismo e Nucleare, correnti con le quali la sua prima produzione manifesta sicure, anche se originali, affinità. Negli ultimi anni Cinquanta la sua opera è stata particolarmente apprezzata da una singolare figura di collezionista e mecenate, quel Charles Damiano, dirigente Pirelli a Londra, appassionato cultore delle ricerche d’avanguardia, che si fa tramite per la conoscenza dell’opera sua, di Lucio Fontana, Roberto Crippa e Gianni Dova presso il pubblico inglese e internazionale, favorendo anche la presenza di loro opere nelle collezioni della Tate Gallery. In stretta relazione con ciascuno di loro, egli cerca di annodare rapporti con collezionisti, galleristi, mercanti e musei internazionali. Dai legami fra Damiano e Clemente, testimoniati da un ricco epistolario, cogliamo anche che all’inizio degli anni Sessanta alcuni problemi di conservazione, derivati dalle tecniche composite con le quali Clemente elaborava allora i suoi dipinti, hanno creato difficoltà e forse anche qualche incomprensione fra di loro. Clemente, che è anche autore di un importante testo servito a presentare le fotografie dello stesso Damiano, oggetto di alcune esposizioni in Inghilterra in quegli anni, vive allora probabilmente una fase di riflessione critica che lo conduce a ulteriori sperimentazioni, nel corso dei primi anni Sessanta, testimoniate da altri lavori in cui riemerge l’ombra, almeno, dell’immagine. La prima sua esposizione personale al Naviglio, che segue quelle tenute a Londra e in altre gallerie, offre ancora opere pittoriche di matrice informale, che saranno però in seguito tralasciate alla ricerca di altre direzioni, di cui le opere della seconda metà degli anni Sessanta costituiscono l’approdo. Rispetto a questo preambolo, necessario per riprendere in esame l’opera di un autore al quale non è stata ancora dedicata una mostra in Italia dopo la morte, avvenuta nel 1974, l’insieme grosso modo unitario dei lavori che sono oggetto di questa occasione costituisce un’importante opportunità. Essi appaiono scanditi attorno a diverse fasi di sviluppo, riconoscibili negli spostamenti a prima vista minimi, ma essenziali, e possono essere oggetto di attenzione all’interno della loro qualità specifica, che partecipa di un momento di trasformazione decisiva per l’arte di quegli anni.
Un’aspirazione a superare la qualità pittorica in senso proprio è insita in molte forme dell’arte che partecipa delle evoluzioni dell’informale.
Per restare in un orizzonte italiano, fra posizioni che in qualche modo possono avere a che fare, viste a posteriori, con le scelte elaborate in modo anche intuitivo da Clemente nel rivolgersi alla corda come materia compositiva, possiamo pensare da una parte ai “sacchi” di Burri, dall’altra alle “tele grinzate” di Manzoni, due modelli che dimostrano, con l’intenzione di trasformare il materiale di fondo in “materia prima”, la necessità o la possibilità di una fuoriuscita dalla pittura che deriva dalla sostanza stessa del quadro. Si può infatti considerare la corda in qualche modo come un surrogato del materiale che costituisce il supporto di tanta pittura, quella tela che ha conosciuto diverse maniere di essere reinterpretata nel corso del Novecento e di diventare motivo espressivo a sé. La tela scoperta delle opere lasciate volutamente a uno stadio incompiuto da Cézanne potrebbe addirittura essere indicata come preludio di una attenzione per la matericità del supporto stesso, che verrà in seguito combinata con altre esperienze di analisi del processo pittorico, per giungere al valore autonomamente materico e compiutamente formale delle opere di Burri del secondo dopoguerra, ma anche delle successive valorizzazioni della componente aggettante della tela, come accade in Scarpitta, in Castellani e in altri ancora.
Questa attenzione per il valore della materia del supporto, ingrandita nelle tramature, allargata e di- venuta in sé componente di strutturazioni che passano per un “grado zero” della pittura, è uno degli aspetti caratterizzanti la nuova forma di quadro ideata da Jack Clemente. Non a caso, essa si struttura inizialmente come volume omogeneo e continuo, nel segno di una ricerca di inespressività formale, che può essere indice della necessaria attenzione per le caratteristiche della nuova materia e tecnica adottata. Di certo, i primi quadri con le corde aggrovigliate in nodi che dichiarano una possibile continuità del gesto che va a comporre la nuova superficie, o che, “cimate”, diventano una specie di campo di efflorescenze senza soluzione di continuità, presentano analogie con quel senso di neutralità indagato dagli “achrome” di Manzoni, nella forma delle “ovatte” che invitano, come le “corde” dei primi “Rituali” di Clemente, alla tattilità, sia anche solo dello sguardo, piuttosto che a un’indagine di natura visiva e formale. Accanto e dentro la scelta di un materiale inusuale, ma che è nella storia stessa della pittura, con il riferimento alle trame del telaio e ad un’azione che genera la composizione attraverso una nuova “cucitura” per la quale diventa interessante anche la verifica dell’unione fra tecnica e risultato, nel retro dell’opera vi è indubbiamente anche il passaggio proprio di tante realizzazioni degli anni Sessanta, dalla valenza pittorico-rappresentativa a quella eminentemente oggettuale, sulla scorta delle diverse spinte a un neodadaismo che in area francese è cresciuto attorno alle posizioni del Nouveau Réalisme e della riflessione critica di Pierre Restany. Altre spinte a un recupero della dimensione fisica dell’oggettualità della pittura si potevano riscontrare nell’ambito dello stesso Spazialismo, e Roberto Crippa, con i suoi “sugheri”, ne può costituire un emblematico punto di svolta, per quanto integrato nella sua esperienza individuale. La tensione a un’oggettualità del materiale pittorico stesso promuove, alla fine degli anni Cinquanta, ulteriori ragioni di insofferenza per la stagione dell’informale, che si rivela nelle reazioni alla maniera del pastiche pittorico che scaturisce dal pittoricismo stesso, quasi da un rigurgito di naturalismo. Anche un autore come Bonalumi, amico di Clemente, svolge combinazioni materiche tra pittura e materie naturalistiche, nelle sue elaborazioni che vanno a negare la matrice specificamente pittorica, per recuperarne una qualità “oggettuale”. L’oggettualità di Clemente tiene conto, progressivamente, della combinazione di cose e forme che da istanze novorealiste (l’Arman delle compattazioni di tubetti di colore o di materie omogenee di vario genere) spingono verso il più decantato disporsi di immagini e cose in chiave pop, ma resta all’interno della volontà di fare del quadro un quadro, vale a dire una strutturazione velatamente pittorica della superficie aggettante ottenuta. A metà del decennio viene individuata come caratteristica, in area milanese, la tendenza verso una “pittura oggettuale”, all’insegna della quale vengono inscritti i lavori di un nucleo di artisti come Castellani, Scheggi, Dadamaino, Alviani, Bonalumi, Simeti, tesi a interpretare in modo particolare e differenziato la combinazione di monocromia e forma assunta dal telaio variamente da loro lavorato, in una direzione che ha a che fare con la trasformazione “spaziale” del concetto di quadro, oltre che con nuove formulazioni di una tecnologia elementare del progetto estetico, ma che soprattutto permane all’interno di una riflessione attorno alle ragioni e alla funzione del quadro. L’“oggetto” derivato dal connubio fra tecnica e ma- teriale in Clemente è sempre in funzione del suo essere quadro, anche quando, con elaborazioni ori- ginali, sembra negarne la presenza o la consistenza. Come avviene nell’opera Senza titolo del 1968, dove la superficie del “tappeto” di corda apre un tondo sulla parete sottostante, ritrovando nuova esten- sione nella zona superiore, a completamento quasi della pressione interna della superficie, che spinge il vuoto prodottosi al suo interno verso l’esterno, analogamente a quanto accade appunto in alcune opere fondate sulla variazione della struttura del supporto degli autori testé citati.
Non mi pare pertinente, invece, avanzare confronti con i modelli proposti nell’ambito della costituenda costellazione dell’Arte Povera, proprio per l’insistenza di Clemente in direzione dell’opera-quadro, che, pur svolgendosi con accenti talvolta ironici, non sfonda verso la nuda presentazione di materiali attivi, come accade in Boetti o in seguito in Calzolari o in Zorio. Qualche affinità si può riscontrare con la modulazione tattile della superficie di alcuni oggetti elaborati da Pascali, ma con chiara valenza rappresentativa, più che spettacolarizzante, tanto che quando Clemente riprende a “raccontare” e costruire forme, anche mediante l’introduzione di ulteriori elementi combinatori, lo fa offrendo una dimensione iconica ai corpi materici. L’uso di tasselli di legno regolari, in forma di tavolette rettangolari o di tondi attraversati dalle corde che li annodano alla superficie, porta a un’identificazione di “teste” o di nuove conformazioni variabili, nella serie delle “Proliferazioni”; denominazione che Clemente attribuisce alle opere eseguite in un secondo momento, o anche parallelamente alla prima elaborazione di questo nucleo di opere, per sottolinearne il valore di superfetazioni rispetto alla pittura, esternazioni di un principio compositivo che fa diventare il quadro variabile per effetto del movimento fisico e visivo al quale è soggetto. Qualcosa di arcaico si ritrova anche in questa fase, che riconduce la sua opera a sintonie con un primitivismo da lui stesso apprezzato attraverso la ricerca di sculture extraeuropee di particolare valore espressivo. In certo senso, applicando la semplice manipolazione che deriva dall’unire l’artigianalità quotidiana con l’originalità del singolo pezzo, Clemente dà allora vita a una nuova qualificazione dell’oggetto per la sua valenza sensuale e magica, che dalla tattilità della sua epidermide si trasmette alle nuove soluzioni formali. All’insegna dei “Nuovi feticismi” i suoi pezzi diventano personaggi, figure, totem, nella semplice strutturazione che le assicelle di legno, adoperate come ulteriore motivo segnico-costruttivo, riescono a generare. Come ideogrammi complessi, i protagonisti dei suoi pezzi evocano soggetti stilizzati, dove la presenza umana è richiamata in assenza, fino ad apparire in modo fantasmatico nel lavoro forse più originale di questa ultima, estrema, serie di opere di Clemente, quell’Archeologie del passato, dove compare una divisa mimetica, che potrebbe evocare qualche riflessione attorno alle guerre e al pacifismo, argomento che vede allora nel Vietnam e nei conflitti israelo-palestinesi lo spunto immediato all’interno dello slogan più diffuso del tempo, quell’I Care con il quale si voleva esprimere la necessità di una partecipazione, politica oltre che emotiva, ai drammi del tempo e del mondo. Dal “passato” emerge per Clemente una divisa militare che in realtà è nel presente, assorbita nelle sue corde e nei suoi nodi, che fanno pensare, in questo specifico caso, alle passamanerie e alle medaglie dei “Generali” di Enrico Baj, ma con un intento più esistenziale che ironico o polemico. Se si sono fatti diversi nomi di artisti, all’interno di questa riflessione suscitata dalla osservazione delle opere di Jack Clemente riemerse dalle soffitte e dai magazzini in cui erano custodite, non è per sminuirne l’originalità o relativizzarne la portata, ma per cercare di reinserirle in un contesto e in un momento storico nel quale sono state generate e di cui sono a loro modo una traccia. Come ogni recupero “archeologico”, anche le opere di Jack Clemente sono destinate a contribuire alla rilettura di una situazione, ma anche di un modello espressivo e compositivo, che potrebbe essere ulteriormente esteso. Muovendo proprio dalla loro qualità specifica, la scelta di una materia così affine al supporto della pittura permetterebbe di aprire ulteriori considerazioni sull’uso delle “corde” in chiave oggettuale e compositiva, che da Miró il quale, in Corde et personagges I, del 1935, sovrappone alla pittura una corda attorcigliata, nella fase di esplorazione delle componenti materico-scultoree che vanno oltre la pittura porterebbe agli autori citati, attivi fra gli anni Cinquanta e Sessanta, per arrivare a Claudio Cintoli, Angelo Savelli, fino a singole opere di Boetti, Merz, Kounellis, e che potrebbe costituire un altro dei tanti percorsi iconografico-metaforici secondo i quali si può rileggere quel recente passato di cui una personalità anomala, originale e a suo modo anarchica, come quella di Jack Clemente, è stata attiva indagatrice e interprete.