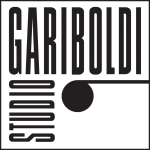novembre – dicembre 2014
L’appassionante mondo di Salvatore Scarpitta
di Luigi Sansone
Se diamo uno sguardo d’insieme all’intera opera artistica di Salvatore Scarpitta la possiamo suddividere in due periodi: il periodo italiano e quello americano.
Il primo si svolge essenzialmente a Roma e comprende un’ampia fascia della sua produzione con gli esordi espressionisti, la fase astratto-figurativa che sbocca nell’informale con le pitture materiche, la realizzazione delle tele estroflesse e infine dei primi quadri con le fasce, esposti alla Galleria La Tartaruga di Plinio De Martis nell’aprile 1958.
Il periodo americano inizia con la mostra da Leo Castelli a New York, nel gennaio 1959 e termina nel 2007, anno della morte dell’artista.
La fase americana di Scarpitta, ricca di spunti creativi, sviluppa ampiamente il tema delle fasce e si orienta inoltre in quattro principali direzioni: la geometrica realizzazione di opere con la significativa struttura a “X”; l’innesto vitale di materiali provenienti dal mondo delle corse d’auto (cinture di sicurezza, tubi di scappamento, frammenti d’auto) nei suoi lavori con le fasce; la costruzione di auto da corsa (alcune “finte” come Rajo Jack, altre perfettamente funzionanti che hanno partecipato a innumerevoli competizioni sui circuiti di terra battuta del Maryland e della Pennsylvania); la realizzazione di slitte e di strutture da traino ispirate al mondo dei nativi americani.
“La tela cruda e grezza”
Gli ultimi anni vissuti a Roma sono stati fondamentali per la ricerca artistica di Scarpitta, infatti tra il 1956 e il 1958 egli inizia a realizzare le tele “a rilievo” estroflesse, di cui una Senza titolo (To Cy), 1958, è esposta in questa mostra, e inoltre i quadri “fasciati”.
Senza titolo che sul retro reca la scritta “To Cy”, dedica al pittore americano Cy Twombly che in quel periodo condivideva con Scarpitta lo studio romano in via Margutta, cela sotto la tela lasciata grezza, una struttura di metallo che scorre quasi come una corrente di energia sotterranea, creando in superficie gibbosità, depressioni e grinze.
Dopo l’esperienza dei primi quadri a olio strappati e ricomposti sul telaio (“incominciai a strappare la tela a olio che mi era diventata del tutto ostile”), Ammiraglio, 1957-1959, e Tensione, 1958, Scarpitta avvia, come egli stesso racconta, “un lavoro per ripulire quello che era stato un gesto abbastanza esasperato. Quella materia perduta in qualche modo dovevo ricuperarla, così ho ripulito questa idea che era abbastanza iconoclasta e ho portato la tela da una condizione malvagia ad una condizione più “surreale”, quasi astratta, dovuta alla tela cruda e grezza, non più strappata, ma tirata”. (1)
La tela grezza con tutte le sue qualità naturali, a volte imbevuta di colori organici (vino, caffè, calce, tintura di iodio), diventa la principale materia dei lavori di Scarpitta, che egli piega e foggia infondendole tensioni, lievitazioni, intrecci, depressioni e torsioni, creando originali e dinamiche composizioni, “un genere artistico”, come scrive Gillo Dorfles, “che – già allora – si differenziava nettamente dagli schemi astratti allora in uso a Roma e dintorni (artistici)”. (2)
Lo stesso artista dichiara quale importanza ebbe per lui cimentarsi con la tela “cruda e grezza”: “ho mantenuto l’attenzione sulla tela, per far sì che la tela fosse sempre la protagonista […] sebbene il gesto non mi interessasse, mi interessava invece solo la qualità della tela, la qualità del materiale […] Ho sempre cercato di immedesimarmi sempre più con il materiale, nel suo modo di presentarsi e di essere”. (3)
Queste ultime dichiarazioni di Scarpitta trovano pienamente riscontro nell’opera Senza titolo, (n. 9), 1958, cm 65 x 100, qui esposta per la prima volta, cronologicamente una delle prime opere con le fasce realizzata dall’artista manipolando ritagli di tele diverse sia per spessore che per qualità di trama (tessitura) e larghezza. I frammenti di tela si intrecciano generando un campo di energie contrapposte che dal centro dell’opera si irradiano verso l’esterno, facendo scaturire in superficie l’ energia più segreta del mondo e delle cose; in quest’opera Scarpitta esalta la grana della tela e riduce il colore, tanto evidenziato nei suoi quadri materici nella stagione precedente, a una traccia residua. L’artista rifonda la propria azione partendo dalla “tela cruda e grezza”, che non è più “strappata ma tirata” e posta in tensione sul telaio. (4)
Scrive Scarpitta:”Parlare e spiegarsi, così come la materia che è solamente la tela stessa, rivela la sua stessa trama e la sua forza, le debolezze e le lacerazioni”. (5)
Dunque il colore non è più materia che si espande sulla tela, ma diventa “intrinseco alla tela stessa”.
La ricerca iniziata in Italia prosegue negli Stati Uniti, a New York, dove Scarpitta dal 1959 oltre alle bende irrigidite con resine e colle inizia a utilizzare le fasce elastiche impregnate di vinavil, così dalla matericità delle fasce, l’interesse dell’artista si concentra verso la tensione.
Come afferma Scarpitta “ad un certo momento mi sembrava logico che tirando la tela l’attenzione fosse condotta più sull’elasticità che sulla materia […] L’idea di irrigidire il quadro nasceva dall’esigenza di rendere visibile ogni gesto compiuto, in modo che l’enfasi della tela venisse fuori maggiormente. Era un modo per catturare più il gesto che la tela tirata”. (6)
Nei lavori Birchbark, Grey Whistle e High Bride, tre opere eseguite nel 1960 a New York, l’attenzione di Scarpitta dall’organicità della materia si accentua verso la tensione: nel primo lavoro bende monocrome orizzontali e verticali si intrecciano creando una tridimensionalità particolarmente profonda tra le bende con avvolgimenti di volute che danno alla composizione un chiaro scuro più intenso, ecologicamente richiamando nelle striature del tessuto la vitalità della corteccia di betulla come dal titolo all’opera; negli altri due le bende tese orizzontalmente si fanno più fitte e coprenti giungendo così ad “una forma di tensione più alta, meno rilasciata”.
Nel 1965 Scarpitta realizza anche Cocoa Dust, una composizione di intrecci di fasce trattate con pigmenti organici (lo stesso titolo, Polvere di Cacao, ci rinvia a una delle sostanze con cui l’artista ha dipinto la tela) che cambiano di colore con il tempo o a seconda delle condizioni ambientali (calore, umidità). In questo lavoro oltre a sperimentare l’uso in arte di sostanze non convenzionali (cacao), esperienza fatta anni dopo anche dagli artisti Joseph Beuys e Dieter Roth, Scarpitta pratica un’apertura orizzontale, una “feritoia” tra il fitto intreccio delle fasce, quasi a voler far circolare l’aria e la luce, un gesto di libertà che spezza il senso di claustrofobia che l’artista nutriva nei confronti della tela.
Piero Dorazio che ha conosciuto Scarpitta fin dai suoi esordi romani negli anni Quaranta, ha parlato in varie occasioni dell’importanza del suo lavoro e a proposito delle opere con le fasce e le “fessure” racconta: ”Verso il 1954-58, dopo la nascita di sua figlia Lola, Salvatore aveva portato nel suo studio tutte le fasce di tela adoperate per fasciare la bambina e, dopo averle avvolte intorno a telai, le irrigidiva con una colla e le dipingeva, monocrome, o bianco, o rosso scuro, o blu, lasciando fra un giro e l’altro della fascia delle fessure. Questi spazi vuoti risultavano come dei tagli netti aperti, come delle ferite. Quei lavori mi colpirono molto per la loro originalità e anche per il loro valore in quanto estensione della sua esperienza pittorica: era il primo esemplare passo avanti dopo la provocazione di Burri. Sicché, quando Fontana venne a Roma, lo accompagnai nello studio di Salvatore, come pure, poco dopo, vi accompagnai Leo Castelli, il quale aveva appena aperto la sua galleria a New York. L’anno dopo andai da Fontana e il suo studio era pieno di tele con i celebri tagli, i quali non potevano non essere stati suggeriti dalle fasce di Scarpitta. (7)
Ampie aperture nella tela vengono praticate dall’artista anche in opere di periodi successivi come in Underwood, 1960, Backstop, 1961, Guard, 1961, Racer’s pillow, 1963, Harness for loving, 1964, (in queste ultime due sono inserite anche cinture di sicurezza provenienti dal mondo delle gare automobilistiche frequentato con passione da Scarpitta) e anche nelle opere degli anni Settanta e Ottanta, Pouch and Settelment Sled, Dalton Sled, Equinox, Snowshoe Sled, tutte realizzate nel 1974, Conveyer, 1976, Eco Sled, 1976-1990, e Cow Catcher and Canvas, 1989.
Egli stesso ci spiega il significato di queste “aperture”: “The opening of canvases is not a factor of elegance, but the opening of windows, as an opening to a way to find salvation. (L’apertura nelle tele non è un fattore di eleganza, ma l’apertura di finestre, come un’apertura per cercare una via di salvezza). (8)
Scarpitta già nel 1993, invitato da Achille Bonito Oliva a partecipare con una sala personale alla XLV di Venezia, in un’intervista si era soffermato sul significato dei “grandi pertugi” delle sue tele e sulla convivenza tra l’aspetto concettuale e materico nel suo lavoro :”Io sono un contenutista. Basandomi sul contenuto, cioè sul riferimento alla vita stessa, nel momento in cui si agisce da artista la materia deve essere egualmente inventata proprio come abbiamo fatto noi partendo da zero nel ’45, anche stando in America, in Siberia o, come Robinson Crusoe, in un’isola deserta. La materia è ciò che ti viene dato proprio per estrinsecare la situazione, il contenuto che si intende veicolare. Non voglio parlare di formalismo, ma un risultato senza forma sarebbe un fallimento. La difficoltà sta nella capacità di far durare il contenuto, di farlo vivere a lungo, non per una stagione ma su una traiettoria. E qui voglio citare il mondo femminile, la traiettoria delle donne, che traccia la continuazione della vita. Ed è proprio dalle donne che noi uomini abbiamo molto da imparare, anche a livello intellettuale […] Se un’opera d’arte esprime solo la polarità maschile è un fallimento. Le mie tele sono tele da parto. I grandi pertugi che apro nella superficie, che qualcuno potrebbe interpretare come spazi di un televisore, sottolineano il momento della nascita.” (9)
Le X Frames
Tra le opere-installazioni di Scarpitta di grande formato tutte eseguite nel 1961, composte da vari “moduli” accostati o sovrapposti, con la struttura a forma di X (capostipite di questa serie è X Core, realizzata nel 1959 a New York subito dopo il suo definitivo rientro negli Stati Uniti), si annoverano X Frames, 1961, Kite for Invasion, 1961, Gunner’s Mate, 1961, Senza titolo (Diogenes Arriving), 1961; di queste quattro installazioni solamente Gunner’s Mate è rimasta a tutt’oggi nella forma originaria, le altre tre sono state smontate all’epoca dall’artista e oggi rimangono i singoli pezzi indipendenti l’uno dall’altro, in quanto Scarpitta riteneva le sue installazioni volutamente scomponibili, infatti i “moduli” a X che le componevano erano riunibili in sequenze diverse e intercambiabili.
I lavori che l’artista intitola X Frames sono tavole o anche telai rivestiti e fasciati di tela, in cui croci diagonali emergono dalla superficie come innervature in rilievo. In questi lavori si avverte la ricerca di uno stile minimalista rigoroso contrapposto alle opere degli anni precedenti, un desiderio di essenzialità ed equilibrio.
Alcune di queste opere furono esposte per la prima volta nella mostra Sculpture and Relief (con Bontecou, Chamberlain, Higgins) tenutasi presso la Leo Castelli Gallery a New York, nel maggio-giugno 1961, e subito dopo alla Dwan Gallery di Los Angeles.
L’opera-installazione sopra citata Kite for Invasion, era formata da sei elementi di varie misure; infatti al grande quadro di fondo, erano sovrapposti, a destra e a sinistra, altri due quadri a forma di X, mentre un terzo quadro centrale composto da due trapezi isosceli uniti copriva la parte centrale e due piccole forme triangolari erano innestaste in basso negli angoli del grande quadro di base. L’installazione nel suo insieme è pubblicata sul manifesto che accompagnava la mostra di Scarpitta alla Dwan Gallery, nel 1961.
Quest’opera all’epoca colpì per la struttura originale che rompeva gli schemi tradizionali del rettangolo e del quadrato, infatti in un breve articolo dell’epoca leggiamo che con Kite for Invasion “ Scarpitta ha rotto lo schema convenzionale con forme estremamente interessanti (illustrazioni 1 e 2), molto vicine alle esperienze della New York School più “magica”: forme che attendono una conferma nel futuro, ma che per il momento ci paiono dotate di indubbie qualità artistiche”. (10)
Scarpitta in una conversazione con Carla Lonzi avvenuta nello studio dell’artista a New York nel 1968, racconta la sua esperienza nel creare i quadri a X: “i moduli: io li ho fatti anche, erano qui, ho fatto la mostra da Castelli, nel 1961. I moduli, cioè ripetizioni formali di uno stesso fatto, moltiplicabile, in modo da essere contrapposto o in sequenza o anti-sequenza, in un senso quasi matematico di 1, 3, 5 o di 2, 5, 1, o 1, 4, 6. In questo senso, sequenze già interrotte, già c’erano in piedi nel 1961 da Castelli. Sì, come no? Ma certo, Carla, e ho fatto due mostre: una da Castelli e un’altra, stessa roba, alla Dwan di Los Angeles […] E allora, come dicevo, Carla, questi moduli che ho fatto allora, nel ’61, erano basati sull’X, erano intercambiabili, nel senso che si poteva fare una presentazione più libera. Chi prendeva queste cose mie in casa poteva arrangiarle in un senso numerico, anti-numerico come meglio credeva […] era un fatto abbastanza nuovo, per me, lasciare a chi esponeva i quadri il gusto, se vuoi, di arrangiare queste cose un po’ come meglio credeva. Naturalmente, quando facevo la mostra, poi, mi smentivo, perché li mettevo nella sequenza in cui io avrei voluto […] “. (11)
Nelle installazioni di Scarpitta improntate sulla forma a X, vere e proprie strutture architettoniche in forma pittorica, si percepisce un’affinità e un’anticipazione di alcune tematiche tipiche dei minimalisti americani (Donald Judd, Dan Flavin, Richard Serra, Bruce Nauman, Frank Stella) che orientano la loro ricerca, con modalità e materiali diversi, verso forme elementari e strutture primarie, accentuando il concetto di serialità e di composizioni multiple.
Scarpitta racconta che ai lavori con le fasce elastiche, realizzati nel periodo 1959-60, sono seguiti “i quadri con le X, presentati in una mostra alla Dwan di Los Angeles nel 1961. Le X Frames consistono in un telaio commerciale da pittore foderato di cartone, con una X di sostegno al centro. Di queste ne facevo, non so per quale ragione, due o tre al giorno e le ammucchiavo una vicina all’altra; l’idea era che ognuno potesse organizzarsele come voleva. Volevo dare una visione relativa del lavoro e l’idea era di essere meno coinvolti nella sistemazione finale del lavoro. […] Lo stimolo a realizzarle, anche se assurdo oggi, significava per me qualcosa. In un palazzo americano prima che sia abbattuto si pongono delle X sulle vetrate. Le X sono li per ricordare agli altri che il palazzo è condannato. Qualcosa di queste X appena notate, in quell’anno mi impressionò per cui arrivai a prendere un telaio ed a metterci una X dentro. […] L’immissione della X innestata nel mio lavoro ha cambiato la configurazione obbligata, allora, del rettangolo, per cui immediata conseguenza del successivo lavoro, presentato da Leo Castelli sempre nel 1961, sono stati quadri che non erano più quadrangolari, ma aperti a diverse forme. Rompendo lo schema costrittivo del rettangolo, che era a quell’epoca l’unico campo operativo possibile, volevo cercare di fare circolare aria là dove la tela, con la sua forma, era diventata oppressiva”. (12)
Ma perché la forma della X, uno dei simboli più antichi dell’umanità diviene una costante dell’opera di Scarpitta? Prima dare una risposta a questa domanda vorrei riassumere brevemente alcuni dei significati che la X ha assunto nella nostra cultura.
La X in matematica sostituisce qualsiasi numero sia positivo che negativo, la sua funzione è quella di incognita nel senso che è la cifra da trovare. La X (per) è utilizzata per denotare la moltiplicazione in aritmetica. In biologia la coppia XX di cromosomi caratterizza le femmine dei mammiferi, mentre nei volatili caratterizza gli individui di sesso maschile (ZZ).
La X è anche presente nel “Monogramma di Cristo”, o “Chi-Rho”, nome generato dalle due lettere greche componenti il simbolo: la “X” (in greco “chi”) e la “P” (in greco “rho) che rappresentano le iniziali della parola Khristòs che nell’antica lingua significava “unto”, parola che veniva usata per identificare Gesù. Inoltre la Croce di S. Andrea (in latino crux decussata) chiamata così perché su una croce di questa forma, cioè con i bracci posti in diagonale “a X”, e non perpendicolarmente, fu messo e fatto morire l’apostolo Andrea, legato o inchiodato con braccia e gambe divaricate; famosi i dipinti rappresentanti Il martirio di Sant’Andrea (1675) di Bartolomé Esteban Murillo (Museo del Prado) e di Mattia Preti (Chiesa di Sant’Andrea della Valle, a Roma), mentre Carlo Dolci in S. Andrea in preghiera davanti la croce (1646), conservato Palazzo Pitti, Firenze, rappresenta il santo inginocchiato davanti alla possente croce pochi attimi prima del martirio.
L’intera opera di Scarpitta è pervasa da un senso di sacralità, lo stesso artista ha dichiarato che le “fasciature” dei suoi quadri “sono state un’esperienza italiana tra le più religiose. Nella mia memoria il primo collegamento è con il fazzoletto di Veronica sul volto di Cristo, ma allora, credendo di essere ateo, non intendevo la religiosità se non in senso laico”. (13)
Questo senso di sacralità è ben espresso in Panciera, 1959, un’opera di piccolo formato, in cui Scarpitta copre la “X” di base con una larga benda (“fazzoletto”) che lascia intuire il punto di incontro della due diagonali che formano la croce di Sant’Andrea, segno di sofferenza a cui porge conforto la protettiva fascia trasversale.
Anche in altre opere come ad esempio St. Andrews Staples, 1961, Box Kite, 1961, Homage au bœuf écorché (14), 1961, (quest’ultima ispirata al dipinto Il bue squartato, 1655, di Rembrandt), Avon X, 1962, X Caged Poncho, 1974, Bandolier, 1979, la struttura della “X” è ricorrente e si riallaccia a una iniziale sacralità legata alla croce di Sant’Andrea (croce decussata) come dichiaratamente espresso nei tre quadri intitolati Croce di Sant’Andrea, eseguiti nel 1959. In questi ultimi tre lavori egli abbina la figura della X alla presenza di numerosi tagli netti che rappresentano una realtà maggiormente sentita, una sofferta intima presenza a cui non è facile sottrarsi:”nonostante la volontà di autocontrollo mi avesse portato a “raffreddare” un certo espressionismo della mia pittura, dagli “ectoplasmi” precedenti le fasciature fino alle “croci di S. Andrea”, sono stato spesso sbrigativamente definito espressionista. Ma il mio entroterra, come per Fontana, era classico. Se poi consideriamo il taglio, per lui è stato un fatto gestuale, nel mio caso, invece, la necessità di aprire la tela al fine di rendere tangibile una forma di realtà maggiore, non un fatto di “stile” ma una diversa concretezza di contenuti”. (15)
Le X, come Scarpitta spesso raccontava, alludono anche al senso di esclusione e a tutti gli ostacoli e impedimenti che egli ha incontrato nella sua vita di artista, come il dramma dello sbarramento opposto dal mondo artistico di New York che egli ha dovuto affrontare al suo ritorno negli Stati Uniti alla fine del 1958, dopo più di venti anni trascorsi in Italia; inoltre, in quanto ricoperte da fasce, le X rappresentano anche una protezione, una difesa, un limite all’invadenza e alla prevaricazione, a tutela della propria vita:”Quando sono tornato, l’America era per me un paese completamente nuovo, da scoprire. […] Non è stato facile riabituarmi alla vita americana. All’inizio mi sono sentito solo, qui mancava assolutamente il senso di aggregazione che si respirava in Italia […] Non mi riconoscevano più come americano, era un periodo in cui tutti erano maledettamente imperialisti sciovinisti!”. (16)
Extramurals: tra pittura e scultura
Poche settimane dopo il suo ritorno negli Stati Uniti si inaugura alla Leo Castelli Gallery di New York, gennaio 1959, la mostra Salvatore Scarpitta – Extramurals, la prima di una lunga serie di mostre personali e collettive che sancirà un quarantennale rapporto di amicizia e di lavoro tra Scarpitta e Leo Castelli. Nel recensirla sul “New York Post” Bennet Schiff si sofferma sull’originalità del lavoro di Scrpitta:”L’arte di Salvatore Scarpitta è qualcosa di completamente nuovo rispetto a quanto è stato fatto fino ad ora […] Così nell’anno 1959 abbiamo qualcosa di nuovo”. (17)
I tridimensionali lavori esposti da Castelli definiti Extramurals, come lo stesso Scarpitta afferma invadevano “lo spazio non più in un senso pittorico, ma in un senso, direi quasi, architettonico.”(18)
Scarpitta in realtà è molto più pittore di quanto in genere si pensi: quasi sempre le sue composizioni sono abili e meditate strutturazioni, dove un elemento figurale (cintura, frammento d’auto, gancio) si associa agli elementi pittorici (resine, macchie dipinte, spruzzi, e miscele organiche composte da caffè, tè, tintura di iodio) e concorre a formare un tutto sommamente unitario, come per esempio in Barefoot e Harness for loving, entrambi del 1964. Queste due opere in particolare, ma anche altre di questo periodo, sono ispirate al mondo delle gare automobilistiche e preannunciano la costruzione di auto da corsa e la sua partecipazione negli anni Ottanta alle gare sulle piste del Maryland e della Pennsylvania. Sono opere che trasmettono una completa espressione della vastità del suo mondo interiore: dai tagli profondi alle fasce strettamente avvolte che li delimitano, a cinghie, fibbie e bulloni che legano e proteggono.
L’uso di incorporare frammenti d’auto nei suoi lavori è per Scarpitta un modo di ricordare o prolungare la vita dei giovani piloti morti in incidenti sui circuiti:”Ho incominciato ad adoperare certe cose legate alle tele come cinture di sicurezza, fibbie da arnese di corridore, fibbie da paracadutista, allacci di tipo aeronautico o da macchine da corsa , tubi di scappamento e ho innestato queste cose nella mia tela, un po’ per riportarmi verso un mondo…più…che rassicurasse più la mia presenza qui, in America […] Ho adoperato un po’ il mio ambiente che cercavo, un ambiente di protezione umana in un mondo organico-meccanicistico”. (19)
L’opera Out Rider, 1970, dà l’avvio ad una serie di lavori in cui la ripartizione orizzontale dello spazio, in questo caso scansito simmetricamente da quattro elementi fasciati, è interrotta da una struttura cilindrica centrale anch’essa fasciata disposta verticalmente che cela il punto di intersezione dei bracci di una croce decussata. Questo schema compositivo con varianti sarà riproposto dall’artista in altri lavori realizzati nella seconda metà degli anni settanta ( Day Rider, 1978, Baton Noire, Breast Plate, Trolley, Bendix, Archer e Chalice, questi ultimi sei tutti realizzati nel 1979).
Note
1 – G. Celant, Salvatore Scarpitta, catalogo, Gallerie Notizie, Torino, e Studio C, Brescia, 1972.
2 – G. Dorfles, Scarpitta 1958-1963, Galleria dell’Ariete, Milano, 1964.
3 – G. Celant, Salvatore Scarpitta, op. cit.
4 – Ibidem.
5 – S. Scarpitta, in “Scarpitta”, catalogo, Galleria La Tartaruga, Roma, 1958)
6 – G. Celant, op. cit.
7 – P. Dorazio, Per Salvatore Scarpitta, in “Scarpitta”, a cura di L. Sansone, cat. mostra, Mazzotta, Milano, 1998, pp. 35-36.
8 – AA.VV., “Salvatore Scarpitta – Outlaw Art at Racing Speeds”, catalogo, Artcar Museum, Houston, Texas, Mazzotta, Milano, 2001.
9 – Salvatore Scarpitta, intervista di S. Zannier, in “Flash Art” – Quotidiano della XLV Biennale di Venezia, 13 giugno 1993.
10 – I simboli ottici crescono: Scarpitta, in “Metro”, n. 3, 1961, B. Alfieri Ed. Milano, pp. 88-89.
11 – C. Lonzi, Autoritratto, De Donato, Bari 1969, pp. 90-91.
12 – G. Celant, Salvatore Scarpitta, op. Cit.
13 – A. Guillot (intervista), Il caso Scarpitta, in “Carte d’Arte Internazionale”, Messina, primavera-estate, 2000, p. 40.
14 – Elena Pontiggia a proposito del Bue squartato scrive che esso è un “omaggio a tutto ciò che nella vita è vittima di violenze, di repressioni ed esprime efficacemente le contrastanti energie distruttive e costruttive che contraddistinguono la pratica artistica dell’italo-americano”. In “Scarpitta”, catalogo, a cura di G. Niccoli e L. Sansone, Centro d’Arte Arbur, 23 novembre-27 gennaio 2001; testi di L. Giudici, F. Gualdoni, P. Dorazio, M. Meneguzzo, E. Pontiggia, L. Sansone.
15 – A. Guillot (intervista), Il caso Scarpitta, in “Carte d’Arte Internazionale”, Messina, primavera-estate, 2000, p. 40.
16 – Dall’intervista di Magda Gandolfi a Salvatore Scarpitta, New York, giugno 2000, in M. Gandolfi, Vita e opere di Salvatore Scarpitta, tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi, Bologna, seconda sessione, anno accademico 1999-2000, p. 54.
17 – B. Schiff, In the Art Gallery, in “New York Post”, 15 febbraio 1959, p. 12.
18 – C. Lonzi Autoritratto cit. p. 90.
19 – Ibidem, pp. 186-187.
Rajo Jack: un’auto da corsa contro la discriminazione razziale
Rajo Jack Spl., 1964, auto da corsa costruita da Scarpitta è dedicata al pilota afro-americano Dewey Gatson (1905-1956), conosciuto come Rajo Jack.
Rajo, nato in Texas, dopo molto girovagare in California adattandosi a svolgere vari mestieri, approda a Legion Ascot, noto circuito d’auto da corsa nei pressi di Hollywood, dove grazie alle sue ottime doti di meccanico viene assunto nella squadra del pilota Francis Quinn; in seguito alla tragica morte di Quinn avvenuta in un incidente stradale, la squadra decide di regalare a Rajo il potente motore Miller appartenuto al pilota scomparso.
Rajo aveva gareggiato negli Stati dell’Idaho, Nevada, Arizona, Kansas ma soprattutto sui circuiti della costa del Pacifico vincendo, tra il 1934 e 1937, a Silvergate (San Diego) e a San Jose e Oakland, in California.
A causa dei pregiudizi razziali però Rajo non poté mai far parte dell’American Automobile Association (AAA) e di conseguenza correre, come avrebbe certamente desiderato, a Indianapolis e a Legion Ascot.
Rajo nella sua vita dovette affrontare una doppia sfida, quella sui circuiti e quella più dura contro la discriminazione razziale. Morì nel 1956 colpito da emorragia cerebrale, mentre alla guida di un’auto attraversava il deserto della California in uno dei tanti viaggi da ovest a est.
Un personaggio come Rajo, così ricco di umanità, coraggio e determinazione, non poteva non colpire Scarpitta che nel 1964 circa si imbatte in una fotografia che ritrae Rajo vicino a una delle prime auto da corsa; dopo un’accurata ricerca egli decide di costruire un’auto d’epoca e di dedicargliela: nasce così Rajo Jack Spl., 1964, la prima auto da corsa realizzata interamente da Scarpitta con materiali trovati e pezzi costruiti da lui stesso nello studio al quarto piano del 333 do Park Avenue South di New York.
L’artista in un bozzetto preparatorio a inchiostro per Rajo, accanto all’immagine dell’auto annota in inglese “facsimile with original parts […] wooden frame, fibreglas engine casting. Body re-constructed from original. Dayton wheels authentic also headers, and Flynn carbs” (facsimile con parti originali […] telaio in legno, calco di motore in fibra di vetro. Carrozzeria ricostruita sull’originale. Ruote autentiche Dayton come anche i collettori e carburatori Flynn).
Come lo stesso artista racconta Rajo Jack:”non esisteva come fatto meccanico, esisteva solamente come copia, come facsimile, era un inganno ottico. “Quella macchina lì, Rajo Jack, è completamente fasulla, ah!…ah!…Però è lì. E la sua apparenza è esatta, è. […] mi sono fabbricato una automobile ottica. Quando l’ho vista…era così vera, stava così bene…”. (1)
L’auto Rajo Jack dunque non è funzionante, ma rappresenta un personale atto di contestazione, un atto politico e di protesta sociale dell’artista verso la discriminazione di un pilota nero a cui fu vietato di gareggiare sulle piste ufficiali degli Stati Uniti.
Subito dopo aver completato la ricostruzione di Rajo Jack Spl. Scarpitta la espose nella mostra Salvatore Scarpitta – Racing Cars presso la Leo Castelli Gallery, nel 1965, e in seguito insieme a Ernie Triplett, un’altra auto da corsa da lui costruita e dedicata all’omonimo pilota morto in pista nel 1934 e ad altre auto, nella mostra Scarpitta Race Cars, tenutasi alla Leo Castelli Warehouse nel 1969.
Note
1 – C. Lonzi, Autoritratto, De Donato, Bari 1969.
Un monumento alla pace: il Lince
I rottami della Lince, 1973, autoblindo costruita dalla Lancia durante la seconda guerra mondiale, vengono acquistati nel 1973 da Scarpitta e dal suo amico Fulvio Carosi, collezionista di auto ed esperto di ricostruzione di macchine d’epoca, presso la ditta di demolizioni d’auto di Placucci a Gambettola (Forlì). L’autoblindo dopo la guerra era stata data, negli anni Cinquanta, in dotazione alla polizia di Stato, e precisamente al II Reparto Celere di Padova che l’aveva ceduta dopo alcuni anni alla ditta Placucci per farla demolire. Al momento del ritrovamento, nella ditta di rottamazione, la Lince si presentava tagliata orizzontalmente in due parti e alcuni pezzi risultavano mancanti. Scarpitta e Carosi dopo un lungo e paziente lavoro di ricostruzione rendono la Lince perfettamente funzionante. Scarpitta decide di dare all’autoblindo una nuova “pelle”, più rassicurante, color rosa sabbia, in contrasto con la tonalità grigio chiaro che aveva quando fu trovata tra i rottami.
Questa “scultura veicolare”, come Frank Gillette definisce la Lince, “con la sua presenza autorevole si profila come un enorme animale catturato, sopra ciò che la circonda mantenendo una ferocia indomita che si scontra con il suo stato presente di pacificazione”. (1)
Nell’ottobre 1973, nel cortile della galleria milanese L’Uomo e l’Arte, in occasione della mostra Carosi-Scarpitta, carro leggero Lince (1940), 1973, l’opera viene presentata al pubblico per la prima volta, circondata da tre grandi teloni con lo stemma della Croce rossa bloccata al suolo da grosse cinghie fatte costruire appositamente che, incrociandosi sulla parte superiore del veicolo, formano un’imponente X. La forma della X, le cinghie, le cinture di sicurezza, che come si è visto ricorrono spesso nelle opere dell’artista, in questo caso compaiono per la prima volta in un’installazione. Dunque le cinghie incrociate contribuiscono a immobilizzare e “catturare” la Lince, strumento di aggressività, che viene così domato e poi disarmato da Scarpitta: infatti egli blocca la mitraglia saldando all’imboccatura della canna un tondo di ferro. Il colore militare dell’intera struttura di acciaio, sostituito da un rosa sabbia, durante l’allestimento viene dall’artista picchiettato di grasso, per trasmettere un avvertimento:”Non toccare! Questa è una realtà da non toccare!” Inoltre i teloni con la croce rossa sono riempiti d’acqua, quasi l’artista volesse purificare e redimere il mezzo dal suo originale carico di morte. Così egli ha voluto trasformare una macchina costruita per distruggere in uno strumento innocuo che assurge a simbolo di come l’uomo possa scegliere tra il bene e il male, tra l’odio e l’amore, tra la vita e la morte. Un carro armato, dichiara Scarpitta, “può diventare pacifico come un camioncino per la consegna del latte se viene legato e bloccato”. (2)
Note
1 – F. Gillette, Scarpitta, catalogo mostra, Galleria Niccoli, Parma, 1990, p. 11.
2 – Per maggiore notizie sull’opera Lince si rimanda a Salvatore Scarpitta. Catalogue Raisonné, a cura di L. Sansone, Mazzotta editore, Milano, 2005, pp. 36-39.
Scarpitta e le auto da corsa: una passione innata
Scarpitta in un’intervista del 2003 così racconta il suo primo impatto con le auto da corsa di cui da bambino sentiva in lontananza, abitando a poca distanza dal circuito di Legion Ascot, l’assordante rombo dei potenti motori:”La prima volta che me ne interessai, praticamente da bambino, era perché sentivo il boato dei motori a distanza di quattro o cinque chilometri da casa. Perché in una delle nostre primissime case di Los Angeles, si sentiva il rumore della pista di Ascot, che mi interessò enormemente. Era una pista dove allora, dai tubi di scappamento senza marmitta, arrivava questo rombo che eccitava l’immaginazione. […] Poi, destino volle che un giorno un belga che lavorava nel cinema chiese a mio padre se mi poteva portare sulla pista. Così mi portò a vedere le corse e allora il mio occhio si riempì di questa meraviglia: erano eroi. Questi erano gli eroi e mi sono innamorato. Mi sono innamorato delle corse , ma non accademicamente, io vedevo l’uomo. Allora morivano ma tanti, non era come oggi. Allora, se c’era un incidente, il cinquanta per cento non sopravviveva, senza cinture di sicurezza, senza casco. E allora io cominciai a adularli[…] (1)
Dunque la passione di Scarpitta per le auto da corsa risale alla sua adolescenza a Los Angeles, dove ha modo di frequentare agli inizi degli anni Trenta la pista di Legion Ascot Speedway in Boyle Heights, tra le colline alle spalle della città, conosciuta dagli appassionati delle corse come cradle of speed (la culla della velocità) ma anche con il triste nome di killer track (la pista assassina); infatti dal 1924, quando il circuito fu inaugurato, fino alla sua chiusura nel 1936 ventiquattro piloti persero la vita. L’assidua frequentazione di quella pista, l’incontro con i piloti, i meccanici, l’assistere alle premiazioni dei campioni lo hanno indotto a eseguire i suoi primi lavori, come egli stesso racconta:”La prima volta che dipinsi erano i numeri che i corridori amici mi permettevano di disegnare sulle loro lucide vetture multicolori. Cominciai a fare qualche ritratto di questi…”. (2)
Nel 1936 un incidente mortale colpisce per l’ennesima volta il circuito di Legion Ascot, dove il pilota Al Gordon e il suo meccanico Spider Matlock perdono la vita. In seguito a questo drammatico episodio i giornali locali, con a capo William Randolph Hearst, magnate della stampa, invocano la chiusura della pista; qualche mese dopo un incendio doloso appiccato alle tribune distrugge completamente il circuito.
La rovinosa fine di Legion Ascot coincide con la partenza di Scarpitta per l’Italia.
Nell’autunno di quello stesso anno egli si imbarca per raggiungere la Sicilia e poi Roma, dove si iscriverà all’Accademia di Belle Arti.
La partenza dagli Stati Uniti, gli anni di studio a Roma, i tragici avvenimenti della seconda guerra mondiale e il successivo lungo soggiorno a Roma nel dopoguerra lo allontanano per un lungo periodo dalle piste, ma la passione per le corse riesploderà al suo ritorno in America.
Dopo l’esperienza della ricostruzione di alcune auto tra il 1964 e 1969 (Rajo Jack, Hal Special, Ernie Triplett, Railduster, Sal Ardun Special), nell’estate del 1985, dopo mesi di lavoro, Scarpitta porta a compimento nel suo studio-garage di Baltimora, nello stato del Maryland, uno dei sogni di gioventù: la costruzione di una macchina da corsa funzionante (dirt track racer), la Sal Scarpitta Special, in grado di correre sulle piste in terra battuta del Maryland e della Pennsylvania con i maggiori campioni del momento. Nel 1986, con il sostegno morale e materiale di Leo Castelli, Scarpitta mette in pista la Sal Gambler Special, una potente auto di 700-800 HP, della categoria super sprint, guidata da Greg O’Neill e preparata dal meccanico Walt Shriver, uno specialista di motori. In un’intervista di quel periodo Scarpitta esprime tutto il suo entusiasmo per la partecipazione della sua auto alle gare:”La mia auto apparirà come un enorme graffito, ma correrà e noi gareggeremo…dobbiamo farlo. È un prolungamento dei miei sogni, e i miei desideri saranno esauditi quando Greg sarà lì, sulla pista, a fare il suo lavoro. Anche se dobbiamo riportarla indietro accidentata ne farò un’opera d’arte e cercherò di comprargli un’altra auto. Non ci tireremo indietro. Andiamo, dobbiamo andare, andiamo in pista!”. (3)
Scarpitta trova nella competizione fragorosa dei circuiti, tra persone che conservano ancora la capacità di entusiasmarsi e appassionarsi, altre energie ed esperienze che, filtrate dalla sua sensibilità artistica, gli permettono di realizzare installazioni e opere di calda e drammatica umanità, come Incident at Castelli, 1987, Race Car on Idaho potato Track, 1990, Kenny Adam’s Eve (Sling Shot), 1996.
Nell’installazione Race Car on Idaho potato Track, realizzata per la mostra tenutasi nel 1990 alla Greenberg Wilson Gallery, New York, una sua auto da corsa, imbrattata del terriccio della pista dove ha in precedenza gareggiato, poggia su uno strato di patate, mentre sulla parete, tra spruzzi di argilla, l’artista inserisce le visiere trasparenti che i piloti gettano durante la corsa quando si sporcano di fango. I comuni denominatori di questa poetica installazione son dunque la terra (simbolo intercambiabile della vita e della morte) e l’argilla di biblica memoria; le patate, frutti del grembo della terra, e l’auto stanno a sottolineare, come lo stesso Scarpitta dice, che “il track racing è della gente dell’America delle province, la sua sostanza è la terra, non è uno sport ma vita, morte, le salsicce con senape, mangiare il sapore della terra”.
Come si legge nel manifesto stampato per l’occasione, l’installazione è dedicata a Leo Castelli che con la sua sponsorizzazione ha reso possibile la partecipazione alle corse delle auto di Scarpitta:”This show is dedicated to art sponsor Leo Castelli, who has fielded the first art car to compete on the american dirt track circuit.”
Note
1 – Da un’intervista di Mila Vajani a Salvatore Scarpitta, Milano, dicembre 2003; una parte di questa intervista è stata pubblicata in Quel barone rampante sull’albero ero io, a cura di M. Vajani, in “Gente”, 24 agosto 2004.
2 – Da una nota autobiografica di Salvatore Scarpitta, in Scarpitta, catalogo della mostra, Galleria del Naviglio, Milano 1956.
3 – Racing with Sal, intervista di B. Snyder, in “Issue. A Journal for Artists”, primavera 1986, p. 24.
4 – (nota…L. Pozzi, Farfalle e patate, trasgressioni di Sal Scarpitta, in “Il Giornale dell’Arte”, n. 83, novembre 1990.
Un nuovo viaggio dell’immaginazione: le slitte
Intorno al 1973 si arriva a una nuova fase nel lavoro di Scarpitta: quella delle “slitte”, che l’artista considerava “figlie dirette” dei lavori a fasce esposti per la prima volta a Roma alla Galleria La Tartaruga.
Se la costruzione delle auto da corsa scaturiva dai ricordi e dalle esperienze adolescenziali dell’artista a Los Angeles, le slitte, il mezzo più arcaico di trasporto, affiorano silenziose attraverso il tunnel del tempo, dall’infanzia dell’umanità fino a noi: “Una slitta è nella memoria di ogni uomo”, afferma Scarpitta.
Nel suo studio di New York, nell’arco di tempo che va dal 1973 al 1975, con materiali recuperati in giro per la città o con pezzi di telai conservati in studio, Scarpitta costruisce diverse slitte e strutture da traino ispirate al mondo dei nativi americani dei quali egli aveva appreso ad apprezzarne la cultura dal padre infatti con lui si recava nelle riserve indiane in Arizona, Colorado e New Mexico, dove il padre aveva molte amicizie tra le popolazioni locali.
L’idea di realizzare le slitte, come ricorda lo stesso artista, gli venne mentre era alle prese con un telaio di legno per costruire una nuova auto, per la quale gli mancavano le ruote:”Dunque, c’è lì questo telaio di legno, allora la risposta a questo è: “Perché la ruota? Perché le ruote? Perché le ruote? Hai trascinato le tue emozioni in giro per il mondo per 56 anni. Perché guidarlo? Trascinalo, è quello che stai facendo. Allora l’ho trascinato e andava bene. È una slitta. Non c’è dubbio – è una slitta”. (1)
Le slitte costruite da Scarpitta con i materiali più svariati e tenute insieme da fasce imbevute di resine e colori organici, sottratte all’interazione con l’ambiente, dunque statiche, evocano un viaggio silenzioso, il viaggio dello spirito verso nuove mete. Esse rappresentano l’energia spirituale delle origini, quando ogni individuo considerava la propria vita un travagliato viaggio alla ricerca dell’assoluto.
“Ero partito per un viaggio dell’immaginazione: New York era diventata una tundra artica, e queste
slitte erano ora l’unico mezzo possibile per spostarsi […] Ho lavorato alle mie slitte in solitudine, ma ho cercato di infondervi un profondo senso sociale: volevo che trasudassero il sapore di una coralità e di una civiltà. Non ho mai lo spirito di collettività e il senso di appartenere a una comunità che ho respirato negli anni romani di piazza del Popolo e che in America non ho più ritrovato…ora piazza del Popolo era diventata anch’essa una tundra in cui far scivolare le mie slitte”. (2)
Le slitte furono esposte per la prima volta nel 1975 alla Leo Castelli nella mostra Salvatore Scarpitta – Sleds e poi nel 1977 nella personale al Contemporary Arts Museum di Houston, curata da James Harithas.
Note
1 – S. Scarpitta, in Scarpitta, catalogo, Contemporary Arts Museum, Houston, Texas, 1977.
2 – Dall’intervista di Magda Gandolfi a Salvatore Scarpitta, New York, giugno 2000, in M. Gandolfi, Vita e opere di Salvatore Scarpitta, tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi, Bologna, seconda sessione, anno accademico 1999-2000, p. 110